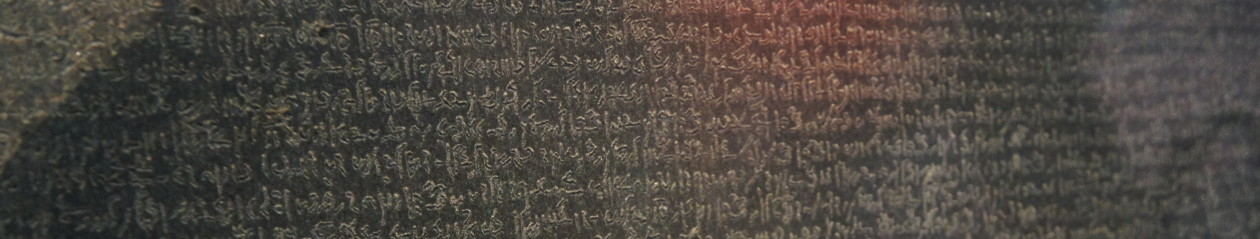PRIMO PIANO / Marcello Buiatti, ordinario di genetica all’Università di Firenze, è da sempre diffidente verso le coltivazioni Ogm. Sia per le incognite scientifiche, sia per tutti i danni collaterali che possono determinare.
“Gli Ogm non fanno male o bene di per sé. La tecnica non fa il pericolo”, spiega: “Il vero problema riguarda quelle piante progettate per resistere ai diserbanti (una delle due possibili modifiche, oltre alla resistenza agli insetti, ndr). Usare più spesso diserbanti, finanche al momento del raccolto, significa che se ne possono trovare residui nel prodotto. Ma di questo non parla mai nessuno”.
I mangimi Ogm possono ‘scalare’ la catena alimentare risalendo a noi dagli animali che mangiamo?
“I geni modificati non ‘entrano’ negli animali, per cui il pericolo è estremamente basso”.
Ritiene che il transgenico possa aiutare a risolvere la fame nel mondo?
“Allo stato attuale gli Ogm non servono a risolvere il problema: il cotone non si mangia, l’olio di colza e la soia certo non aiutano, e il mais viene coltivato soprattutto in America Latina. Gli Ogm inoltre non incrementano la produzione: non fanno bene ai contadini, ma solo a chi li vende”.
Cosa ci si può aspettare nel futuro da questa tecnologia?
“Una tecnologia che si dice avanzata, ma in più di vent’anni ha prodotto solo un paio di ‘migliorie’, con appena quattro piante sul mercato, in qualunque altro campo verrebbe considerata un fallimento. Il fatto è che le piante risentono delle trasformazioni loro imposte, e oppongono una resistenza tale da modificare, o ‘sabotare’, lo stesso gene che proviamo a infilarci. Anche di questo si parla pochissimo”.
E in Italia a chi potranno servire gli Ogm?
“Di mais ne coltiviamo poco, di soia ancor meno. Se la ricerca sugli Ogm si orientasse verso la salvaguardia della nostra biodiversità sarebbe un bene, ma non si fa mai altro che ripetere quanto già si sa. Poi dove arriva l’agricoltura industriale
degli Ogm, come in Brasile e in India, il numero di varietà prodotte si riduce drasticamente. Non è proprio quello di cui avremmo bisogno, ad esempio, in regioni ricche di cibi doc come la Toscana. Per la nostra economia rende molto più un prodotto tipico che non questa ‘roba’ standardizzata”.
(L’Espresso, 4/9/2008)