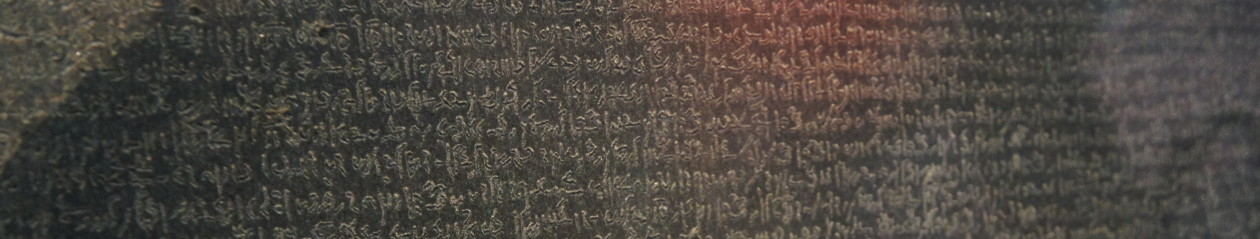Stefano Pitrelli, Europa
INTERVISTA AL ROMANZIERE STATUNITENSE / L’autore di Underworld è in Italia per presentare il suo ultimo libro.
Don DeLillo, tra i più grandi autori americani contemporanei, scarica tutte le colpe sui suoi personaggi. La “colpa” in questione è la sua lucida e impietosa analisi della società americana, della quale ci fornisce – romanzo per romanzo, come fossero tanti tasselli di un mosaico – un sempre più complesso ritratto. DeLillo “si limita” a costruirne il palcoscenico: «Progetto un’architettura più di quanto io non elabori una filosofia» – dichiara in un’intervista rilasciata a Europa in occasione della presentazione del suo ultimo romanzo, Cosmopolis, edito da Einaudi – e poi lascia semplicemente che i personaggi si muovano in essa. Come Eric Packer, protagonista di Cosmopolis, un giovane miliardario in giro per le strade di New York come un Ulisse postmoderno.
«Non sono mai troppo sicuro di come il romanzo prenderà forma», dichiara DeLillo, che si mette a scrivere senza prefiggersi di trattare «un particolare aspetto della cultura». Ma poi «semplicemente succede qualcosa che inonda il romanzo con un senso della cultura intorno ad esso» (il riferimento è in particolare al monumentale affresco di Underworld, sempre edito da Einaudi). Alla fine, osserva, sono «gli stessi personaggi a creare quel mondo». Personaggi che lui «non giudica», e di cui non condivide necessariamente il punto di vista.
Come Vija Kinski in Cosmopolis, perché l’importante, per DeLillo è soltanto che quel punto di vista sia «coerente con il personaggio e con il romanzo», che il personaggio sia vero, insomma. Quello di Kinski è un caso specifico in cui è il personaggio a guidare l’autore «all’interno di certi aspetti della cultura che ci circonda».
Particolarmente vivo nell’opera di DeLillo è sempre il tema dell’influenza dei media sulla società americana, basti prendere quella scena, in Underworld in cui il marito costringe la moglie a guardare l’ennesima replica filmata di un omicidio in diretta, del famigerato Texas Highway Killer: «Lo trasmettono perché devono, perché sono lì proprio per questo, per fornirci i nostri diversivi». O, come in Cosmopolis, la ripetizione delle immagini della morte di Arthur Rapp sugli schermi della tecnologica limousine del protagonista: «Sapeva che avrebbero continuato a trasmetterlo fino a tarda notte, la nostra notte, fino a esaurirne l’impatto emotivo o finché tutto il mondo non l’avesse visto». Senza parlare di Valparaiso, l’opera teatrale che vede la vita di due coniugi “sminuzzata” da microfoni e telecamere di intervista in intervista. «Questo è il modo in cui viviamo – ci spiega – siamo circondati da queste immagini per tutto il tempo. E’ qualcosa che personalmente non potrei ignorare».
Don DeLillo ci tiene a precisare di non sentirsi un «critico dei media», perché il suo obiettivo resta quello di “leggere” ciò che esiste. Ma l’assenza di pregiudizi negativi nei confronti degli stessi media non fa che rendere più tagliente lo sguardo di chi, come lui, «cerca di dissezionare tutto ciò che riguarda la cultura». Il suo lavoro, infatti, è alla ricerca di qualcosa di più profondo di una critica ai mezzi di informazione, e la stessa cultura «è un qualcosa di molto più profondo di quanto appaia al cinema».
Una cultura, quella americana, che c’è anche chi interpreta in quanto potere, benché potere dolce: il cosiddetto “soft power”.
Come a dire la somma di tutti quegli aspetti della cultura americana che sono in grado di influenzare altri popoli e culture.
«Credo che una parte della cultura americana entri in ogni stanza, in ogni casa, in ogni vita, e che questo causi una grande quantità di rabbia e frustrazione nel resto del mondo». «Penso che sia un fattore molto potente», osserva, «ma mi chiedo se le altre nazioni stiano facendo abbastanza per fermare quest’influenza. O se dovrebbero ».
La questione della cultura e della nazionalità trova nella sua biografia una chiave interessante di lettura. Don DeLillo nasce nel Bronx nel ‘36, da una famiglia di origine italiana. E in un quartiere composto perlopiù da italiani. A chi lo critica per aver rigettato le sue origini, l’autore ricorda di aver scritto dei racconti sulla sua infanzia nel quartiere italiano, «ma all’epoca non ero ancora un bravo scrittore». E lo studio, racconta, lo ha portato ad aprirsi, a voler abbracciare una cultura più vasta. Come scrittore americano, e non solo italo-americano.
Lasciandosi dietro “l’etichetta” di etnicità, osserva DeLillo, un autore può esplorare qualunque aspetto della cultura lui scelga, senza rispettare le restrizioni imposte da qualcun altro.
Tantomeno quelle rappresentate dal pubblico: «Non ho in mente una persona particolare per la quale potrei scrivere».
DeLillo ha invece ben chiara l’idea dell’importanza del «linguaggio stesso, questo è ciò cui presto attenzione: le parole». Questo viene per primo, «poi viene lo sviluppo dei personaggi e lo svolgersi degli eventi». Quelli di finzione, e quelli storici: «Non credo di voler spiegare la storia» conclude «ma cerco di inserire i miei racconti in essa».