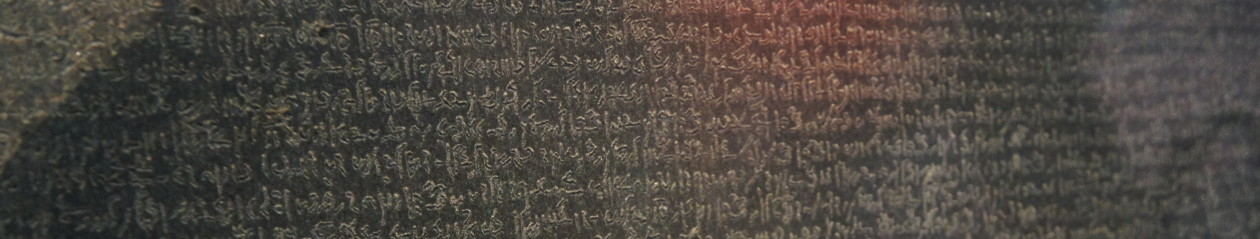ATTUALITA’ : EDILIZIA PUBBLICA – UNO SCANDALO NAZIONALE / Lo Stato ha un patrimonio di case che sul mercato vale 270 miliardi. Ma che dal 2002 al 2006 ci è costato oltre 900 milioni di euro. Tra inquilini morosi, occupazioni abusive e gestioni clientelari.
C’è chi prende un martello e sfonda la porta, per occupare una casa popolare. C’è chi l’ha ereditata dai parenti, ci si trova benissimo e non si schioda di lì. E poi ci sono quelli che ne avrebbero veramente diritto e che invece restano fuori. Perché in Italia gli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica non solo sono pochi, ma sono anche gestiti malissimo. E indebitati oltre l’immaginazione. Così la casa popolare è spesso un miraggio (sia per gli italiani che per gli immigrati che sempre più ne fanno richiesta) e una realtà miseramente fallimentare.
Abusivi e morosi.
Eppure il portafoglio di immobili in mano pubblica è vasto. Secondo gli ultimi dati Federcasa (la federazione degli ex Iacp, Istituti autonomi delle case popolari) supera ampiamente il milione e 100 mila unità: 928 mila alloggi gestiti dagli ex Iacp, e circa 200 mila direttamente dai comuni. Un patrimonio dislocato soprattutto nelle aree metropolitane: quasi la metà è situata nei principali capoluoghi, con in testa Milano, Roma, Napoli, Torino e Bari. Insomma, un vero tesoro per le finanze pubbliche, visto che secondo uno studio di Patrimonio dello Stato spa (società controllata dal ministero dell’Economia), il valore catastale si aggira sui 90 miliardi di euro. Cifra destinata ad aumentare se si prende come riferimento il valore reale, ossia quello di mercato: qui si arriva a 270 miliardi, ben tre volte tanto.
Ebbene, nonostante questi valori da capogiro, ogni anno le case popolari sono una perdita secca per la collettività. Basta prendere i dati Federcasa sui bilanci degli ex Iacp (che oggi hanno nomi diversi come Ater, Atc e Acer) per avere un’idea di quanto ci costano. Negli ultimi cinque anni, dal 2002 al 2006, hanno perso qualcosa come 938 milioni di euro. Emblematico il caso pugliese: dal 2000 tutti e cinque gli Ater provinciali sono commissariati, e quelli di Brindisi e Taranto in particolare sono in dissesto finanziario. Se allarghiamo lo spettro, non se la passano bene neanche quelli di Roma e Napoli, oberati dai debiti e sull’orlo del crack.
Cos’è che non va nel mattone popolare? A parte le accuse di gestione clientelare degli alloggi, c’è da dire che i ricavi di questi istituti sono scarsi rispetto a costi crescenti. Le entrate si fondano sui canoni, che sono per loro natura molto bassi. Basti pensare che secondo la Corte dei conti a Napoli si affitta una casa popolare in media a 42 euro al mese, 58 a Bari e 60 a Palermo. Quattro soldi, che spesso vengono versati solo in parte, oppure non pagati del tutto. È l’effetto del doppio fenomeno morosità-abusivismo. Sempre secondo Federcasa, negli ultimi cinque anni circa il 15 per cento degli inquilini non ha pagato l’affitto, per un danno che si aggira sui 110 milioni annui. Senza considerare poi gli alloggi totalmente fuori controllo, occupati abusivamente da chi ci entra sfondando la porta. Nel 2004 se ne contavano più di 40 mila in tutta Italia, concentrati soprattutto nelle grandi città. Un dato in diminuzione rispetto ai 52 mila del 2000, e ai 44 mila del 2003, ma non per merito dell’azione di contrasto degli istituti: il fatto è che molte Regioni hanno scelto la strada delle sanatorie. A Napoli, ad esempio, tre leggi regionali in successione hanno permesso a 7.357 abusivi (su un totale di 8.640) di diventare regolari. Lo stesso a Bari, dove grazie a una legge del 2004 circa 1.500 famiglie si sono regolarizzate pagando solo il 30 per cento della morosità pregressa. A ciò si aggiunge che spesso il recupero della case occupate è diventato quasi impossibile. Sempre a Napoli, e nel suo hinterland, interi palazzi popolari sono gestiti dalla camorra: succede alle Vele di Scampia, al rione Villa a Poggioreale e a diversi caseggiati di Ponticelli e Torre Annunziata.
Canoni bassi, morosità e abusivismo.
A tutto questo si deve aggiungere che gli ex Iacp devono far fronte a spese importanti: i costi di manutenzione sempre in aumento (gli alloggi sono vecchi, in Italia non si costruiscono case popolari da più di 20 anni); gli stipendi dei 7.250 dipendenti (aumentati del 40 per cento negli ultimi cinque anni); infine le decine di milioni di euro che se ne vanno in tasse, Ici in testa. In totale quasi 200 milioni l’anno di buco, che a rigor di legge dovrebbero essere ripianati dalle Regioni, ma che invece restano sul groppone degli enti. “Voglio smentire il falso mito delle Regioni che coprono i buchi di bilancio”, precisa Anna Maria Pozzo, direttore tecnico di Federcasa: “Avviene il contrario, spesso i governatori stornano i fondi per l’edilizia pubblica per destinarli ad altri capitoli di bilancio, come la sanità”. Sta di fatto che, per coprire perdite e debiti, negli ultimi anni gli Ater hanno cominciato a vendere gli alloggi agli inquilini. Un palliativo: secondo la Corte dei conti, dal 1994 al 2003 sono state cedute circa 71 mila case, e con scarsi risultati. Gli 1,7 miliardi incamerati sono molto meno del previsto, anche perché la legge impone di vendere a prezzi di assoluto favore. Ovvero al valore catastale (a volte irrisorio), e per lo più scontato del 20 per cento.
Disastro Roma.
Con 2.800 famiglie romane ai vertici delle graduatorie, in perpetua attesa di una casa popolare, per molti versi la situazione romana rappresenta il peggio nel panorama degli Ater. Da una parte un debito orbitante intorno al miliardo di euro (che, aggravato da una morosità al 36 per cento, cresce di 100 euro al minuto). Dall’altro il caso della ‘svendopoli’, che ha visto il presidente della regione Pietro Marrazzo chiedere la sospensione delle vendite immobiliari in corso. Vendite che avevano portato a cedere appartamenti a Testaccio e San Saba (quartieri ‘hot’ della capitale) a costi irrisori. “Se non ci portassimo dietro il debito ereditato dal vecchio Iacp ce la caveremmo da soli”, spiega Luca Petrucci, presidente dell’ente romano. Il problema, dice, è l’Ater in sé, che è diventato “di supporto a un ceto medio privilegiato, perché di veri poveri ce ne sono rimasti pochi, con tanti residenti di seconda e terza generazione”. Per cui magari ci trovi a vivere “il nipote del vecchio assegnatario, direttore di banca, che con noi non c’entrerebbe niente”, e non c’è invece “un patrimonio da dare ai più deboli”.
Evidentemente non sono solo i conti a non quadrare, negli Ater. Come spiega Antonio Tosi, docente di sociologia urbana e politiche della casa al Politecnico di Milano, “si va spesso a coprire una fascia che avrà dei problemi, ma non i peggiori: si trascurano i redditi più bassi e la marginalità, mentre non si riesce a buttar fuori chi ha superato i limiti di reddito”. Ereditarietà e abusivismo non sono che due facce della stessa medaglia.
Torino virtuosa.
Con circa 30 mila alloggi, l’Atc (l’Ater torinese) è il quarto in Italia per numero di appartamenti gestiti. L’edilizia pubblica a Torino, secondo la Pozzo, rappresenta “un esempio virtuoso”. E per più di un aspetto. Innanzitutto il bilancio, che è in positivo. E poi un numero bassissimo di alloggi occupati abusivamente. Per far funzionare l’azienda (con un canone medio teorico che si è andato riducendo fino a 92 euro, e un 67 per cento di inquilini senza reddito) la ricetta di Ardito è quella della tolleranza zero verso gli irregolari. E questo a fronte di una morosità significativa, denunciata dalla Corte dei conti: “A Torino un inquilino su quattro non paga l’affitto”. Per affrontare il problema nell’ultimo anno ci sono stati 6 mila controlli e 500 sfratti, mentre parte della morosità è rientrata grazie alla rateizzazione dei pagamenti. Alla tolleranza zero si aggiunge poi un’intensa operazione di marketing, che include l’affitto delle facciate per la pubblicità e dei tetti per i ripetitori, ma che vede soprattutto l’Atc impegnata nell’incentivare i comuni ad accedere ai bandi regionali: “Così poi le case gliele costruiamo noi. E più ne gestiamo, più i bilanci funzionano”.
Il fronte immigrazione.
Un caso a parte nell’ambito dell’edilizia popolare è quello degli immigrati stranieri, che i più recenti rapporti Nomisma descrivono come in forte crescita, con oltre due milioni e mezzo di presenze nel 2006. Fenomeno che, se da un lato conta il 10 per cento delle compravendite nel mercato immobiliare ‘normale’ (con picchi vicini al 20 nelle periferie delle città del Nord), fa sentire la sua presenza nell’edilizia pubblica, con 73.761 alloggi nel 2004 (dati Federcasa) e una crescita del 36 per cento sul 2001. Federcasa li colloca al 4 per cento della popolazione complessiva (con netta prevalenza al Nord), compresa una minoranza di nomadi regolari.
Per farsene un’idea basti prendere il caso di Padova, dove su 2.735 alloggi dell’Ater, 196 (il 7,2 per cento) risultano in affitto a cittadini stranieri. Una crescita favorita altresì dai criteri di assegnazione, che oltre al reddito, alle condizioni abitative e agli handicap, “tengono conto del numero dei figli”, spiega la Pozzo, “spingendoli così in testa alla graduatoria”. Un rischio banlieue? Tosi tende a scartare questa possibilità: “I numeri italiani sono ben lontani da quelli francesi, e anche se fosse, il caso banlieue è il frutto del fallimento di politiche d’integrazione, non dell’edilizia pubblica”. Frammentata, infine, è la modalità con cui un immigrato può vedersi assegnato un alloggio: se in regioni come l’Emilia Romagna le condizioni sono di parità con quelle degli italiani, in Umbria sono necessari ben tre anni di residenza regolare.
Non che per gli italiani le regole siano più lineari. I criteri adottati a livello regionale per aprire le porte dell’edilizia residenziale pubblica variano. E di molto. Su 16 regioni, i limiti di reddito dei bandi d’accesso fanno un bel salto dagli 11.465 euro della Sardegna ai 24.645 del Piemonte. E in generale restano mediamente fra i 13 e i 14 mila al Centro e al Sud, volando oltre i 16mila al Nord.
Non è l’unica disuguaglianza da considerare, se si tiene conto di chi un tetto sulla testa non ce l’ha. Una volta persi dati importanti come quelli della residenza, e in assenza di una pensione, i senza dimora restano spesso tagliati fuori, come spiega l’associazione Avvocato di Strada.
L’Europa è lontana.
Quale futuro allora per l’edilizia popolare? L’unica cosa certa è la sua indispensabilità, soprattutto considerando che la richiesta di alloggi è molto più alta dell’offerta disponibile. Secondo l’indagine Anci-Cresme 2005, solo il 7,9 per cento delle domande viene soddisfatta. Per ovviare a questa frattura, gli Ater hanno messo in cantiere un piano pluriennale di nuovi investimenti: entro il 2012 dovrebbero essere pronti 28 mila alloggi, fra nuove costruzioni e immobili recuperati. La portata del progetto sembra francamente un po’ ottimistica se si considerano le scarse risorse e i tanti debiti cui devono far fronte.
Del resto, anche vendere vecchi immobili per comprarne nuovi non risolve il problema: per la Corte dei conti “il rapporto è di 3 a 1”, chiaramente a svantaggio degli istituti. Anche per questo la Pozzo chiede al governo “un fondo assistenziale che si faccia carico della funzione sociale degli ex Iacp”. A parte l’intervento statale, si stanno comunque facendo largo modelli alternativi all’esperienza degli istituti per le case popolari. A fare da battistrada è la Toscana, che gli Ater li ha addirittura eliminati, trasferendo la proprietà delle case ai comuni, e passando la gestione a società per azioni a capitale pubblico; poi c’è il modello emiliano, in cui le società a controllo comunale vengono sostituite da agenzie regionali. Altra strada, infine, è quella di un nuovo social housing in cui, come spiega Edoardo Reviglio, economista e conoscitore del patrimonio statale, “investitore pubblico e privato si incontrano per costruire nuove abitazioni a tassi di profitto etici e canoni agevolati”.
Insomma, se ne parla tanto, ma l’Italia per ora resta lontana dall’Europa, dove, come succede con i 3 milioni e mezzo di alloggi della Francia e i 3 milioni e 100 mila della Gran Bretagna, le case popolari oggi sono tre volte le nostre.
(L’Espresso, 5/12/2007)